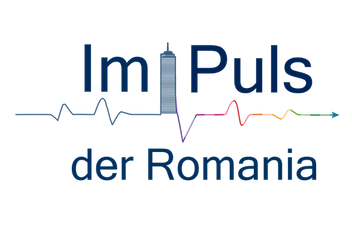Speaker
Description
Il presente contributo si pone l’obiettivo di indagare la correlazione tra scrittura saggistica e narrativa - e le ricadute stilistiche di tale ibridismo - all’interno di una delle opere più celebri della bibliografia magrisiana, il “romanzo-saggio” Danubio (1986). Lontano dalla medietà linguistica, in Danubio Magris utilizza uno stile “fluviale” (Coletti, 2022), quid medium tra gusto critico e narrato, che vale all’autore la nomina di “affascinante miscelatore di saggio e racconto” (Mengaldo, 1998) e all’opera la definizione di “saggio narrativo” o “romanzo critico” (Governatori, 1999), con la conseguente affiliazione al “genere intermedio” (Sergio, 2020).
Dalla saggistica, “forse il più mutevole e inafferrabile dei generi” (Berardinelli, 2002), l’autore friulano ricava la tendenza alla frammentarietà sintattica: l’impiego di una ricca aggettivazione, un’elencazione marcata e numerose digressioni storico-biografiche, con citazioni e aneddoti, isocoli e analogie, dilata notevolmente la prosa. Si tratta di un saggismo “multilivellare e incompiuto” (Duprè, 2018), sensibile all’agglutinazione, che riflette la logica di un viaggio per “soste” (Pellegrini, 1997).
Alla prosa narrativa, invece, fanno affidamento le sequenze “trainanti” del romanzo, le quali riconducono il racconto entro i binari della storia: sequenze dinamiche e descrittive, da reportage di viaggio, ma anche vivi spaccati psicologici dei personaggi del “vagabondaggio culturale” (Mengaldo, 1998). Il ritmo della narrazione aumenta, così come si accorcia la sintassi, che in queste sequenze si fa più sobria, con un uso moderato di incisi e frasi relative, rivelando la prospettiva dell’io narrante.
La logica compositiva dell’intreccio testuale gioca dunque su di un tessuto elastico, che media la dicotomia magrisiana tra caoticità dispersiva e sintesi totalizzante, secondo una forma propria di dispositio sintattica. Attraverso molteplici esempi dal testo, la discussione vuole mostrare come lo stile romanzesco divenga “una strategia per proteggere quegli strappi” (Magris, 1986) lasciati dalla prosa saggistica, formulando un organismo duale che fa delle proprie fratture un quadro unitario.